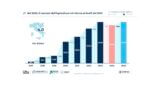Il Position paper di BusinessEurope dedicato a “Omnibus, CS3D, CSRD e TAXONOMY” (il documento integrale è consultabile direttamente qui n.d.r.) arriva in un momento in cui il dibattito sull’approccio normativo alla sostenibilità risulta sempre più acceso con una serie di contrapposizioni che stanno cambiando lo scenario economico di riferimento per l’ESG.
Solo per citare un esempio ha suscitato un particolare interesse la posizione (da alcuni interpretata come una forma di antiambientalismo) assunta dall’ex premier britannico Tony Blair secondo il quale “è sbagliato chiedere alla gente sacrifici finanziari e cambiamenti allo stile di vita quando sanno che il loro impatto sulle emissioni globali è minimo”. (un tema affrontato nell’intervento in cui ci si interroga se la sinistra che diventa antiambientalista n.d.r.)
Pacchetto Omnibus e business: un approccio più pragmatico
Il pacchetto Omnibus proposto dalla Commissione Europea e la sua introduzione sta segnando infatti una fase di ricalibrazione degli impegni e delle misure con un forte impatto sulle strategie e sulle attività economiche. Ne abbiamo parlato con Luca Grassadonia ESG manager che proprio qualche settimana fa ci aveva guidato nell’analisi del Pacchetto Omnibus e della normativa di sostenibilità.
“La logica dell’alleggerimento normativo per le aziende – spiega Grassadonia – sembra essere una prospettiva che piace. Era un provvedimento assolutamente indispensabile, dato che l’Unione Europea aveva intrapreso una strada molto impegnativa con direttive che avevano sollevato molte obiezioni”.
In questo senso si colloca appunto anche il position paper di BusinessEurope sul Pacchetto Omnibus UE, una realtà che rappresenta imprese di tutte le dimensioni in 36 paesi europei attraverso una rete di federazioni nazionali di imprese.
Grassadonia sottolinea subito come molti problemi si siano manifestati già con le prime implementazioni delle normative, costringendo a una frenata e a prendere tempo per rimettere insieme un percorso che, sebbene orientato nella direzione corretta, rischiava di ostacolare l’intero sistema economico a causa di errori nella definizione dei concetti di base, di complessità burocratiche e in alcuni casi anche di ingenuità applicative.
Un cambiamento nel “clima” politico
In questo specifico periodo storico non si può non sottolineare l’importanza di un cambiamento anche molto profondo nell’atteggiamento complessivo delle principali forze politiche e nell’opinione pubblica verso i temi della sostenibilità. Il “clima” in questo caso nel senso di sentiment è indiscutibilmente cambiato e non poche decisioni dell’amministrazione Trump hanno confermato un mutamento di scenario che ha motivazioni profonde e che segna una forte discontinuità con il passato.
Senza nulla togliere a questi segnali Grassadonia sottolinea che “il cambio del quadro internazionale potrebbe non essere così rilevante come sembra. Gli obiettivi di sostenibilità – osserva – rimangono fondamentalmente gli stessi. Erano e restano necessari perché il sistema globale, quello che ha sostenuto lo sviluppo industriale degli ultimi 30 anni, non reggeva più. Quello che è cambiato – prosegue – sono i percorsi per raggiungere questi obiettivi. L’Europa ha scelto di agire a livello di un cambiamento guidato dalla normativa basato su una serie di principi di sostenibilità, che non sempre avevano un corretto corrispettivo nella realtà. Altre parti del pianeta hanno scelto (o in alcuni casi “non” hanno scelto) altri atteggiamenti. Nel caso degli Stati Uniti, che sono oggi costantemente al centro dell’attenzione in virtù dell’attivismo di Trump, si può dire che abbiano scelto un approccio meno legato alla regolamentazione, ma per certi aspetti più pragmatico e drastico.
Omnibus e business: l’approccio europeo e l’idealismo normativo
Dal punto di vista europeo, “ci si è forse fatti prendere la mano dall’idealismo normativo – osserva Grassadonia -. In concreto con questo approccio si è tentato di scaricare sulle imprese interventi che non sono in grado di affrontare, certamente non da sole. Interventi che molto spesso le aziende non sanno come gestire e che, in chiave di sviluppo, non dovrebbero essere tenute a svolgere”.
Dietro a questa consapevolezza si nasconde la ragione vera di questa correzione di rotta: “la realtà si è presentata e ha reso inevitabile cambiare approccio. Gli Stati Uniti, al contrario, hanno avuto un atteggiamento diverso. Mentre l’Europa lavora su questi temi da anni, con iniziative come il Green Deal che ha almeno 5 anni di confronti e progetti alle spalle e con direttive come la DNF (Dichiarazione Non Finanziaria) con quasi dieci anni di esperienze, gli Stati Uniti scontano un ritardo, una visione diversa dei temi della sostenibilità e un rapporto con le risorse a sua volta culturalmente diverso da quello europeo.
Gli squilibri globali e il ruolo dei governi
Il problema di fondo che sta alla base anche del rapporto tra pacchetto Omnibus e business è però lo stesso per tutti e per l’Europa è legato alla convinzione che il sistema imprenditoriale da solo potesse gestire trasformazioni che la politica non era in grado di affrontare. In questo senso va detto che il sistema imprenditoriale ha mostrato inizialmente una importante disponibilità a partecipare ai processi di riaggiustamento degli squilibri strutturali che stavano diventando insostenibili, ma è apparso via via chiaro che questo impegno non poteva essere lasciato solo alle imprese.
Grassadonia puntualizza che gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) sono stati assegnati ai governi e alle nazioni, non alle imprese. Le imprese sono chiamate a contribuire in maniera volontaria per sostenere e accelerare il raggiungimento di tali obiettivi, ma sono i governi che hanno assunto questi impegni. “Non si può chiedere a una singola azienda di combattere la povertà nel mondo – afferma – o meglio, le si deve chiedere di contribuire, ma più in particolare si deve chiedere che ciascuna impresa contribuisca in modo equo a livello competitivo, garantendo il pieno rispetto delle regole”.
Ora, con questo nuovo rapporto che si può identificare nel rapporto tra Pacchetto Omnibus e business si prospetta un riassetto normativo che dovrebbe consentire di mettere in chiaro gli impegni assunti in funzione di ciò che è effettivamente possibile realizzare.
Omnibus e business: oltre la normativa
Grassadonia tiene inoltre a precisare che il percorso normativo, per come è stato concepito inizialmente, ha previsto ad esempio una serie di controlli e sanzioni che sono molto più vicini all’ambito penale che non amministrativo.
Un esempio concreto è la direttiva CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive). Nella sua prima formulazione, ovvero prima del Pacchetto Omnibus, prevedeva il controllo di tutti i fornitori a tutti i livelli e multe pari al 5% del fatturato. C’era anche l’obbligo di interrompere i rapporti commerciali se l’azienda non fosse riuscita a porre rimedio a violazioni dei diritti umani o ambientali. “Questi – sottolinea Grassadonia – sono compiti da ufficiale pubblico. Tali aspetti sono stati rivisti in parte, ma non ancora del tutto, motivo per cui è emersa la necessità di ulteriori interventi”.
L’Omnibus appare in questo senso sicuramente una sorta di ripensamento, ma richiede tempo per rielaborare le norme, e proprio per questo non è ancora un cambiamento completo.
Grassadonia prosegue sottolineando che le soluzioni proposte nel Position paper di BusinessEurope sono in gran parte condivisibili perché basate su problematiche molto concrete. In particolare, uno dei principi chiave menzionati è rappresentato dal tela della certezza del diritto. Ci sono infatti ancora concetti espressi nelle direttive che sono “legalmente poco chiari”. Ad esempio, la natura delle informazioni da raccogliere nella due diligence o le misure da adottare presentano discrepanze tra le direttive stesse. La CSDDD parla di un piano di transizione climatica che deve essere presentato e deve essere implementato, mentre la direttiva sul reporting prevede un piano di transizione che può anche non essere presentato. C’è una mancanza di coerenza tra i vari provvedimenti europei. Si parla di uno stesso tema, ma le direttive impongono di affrontarlo in modi diversi, creando confusione.
Un’altra discrepanza riguarda l’applicazione richiesta e i requisiti applicativi tra il settore finanziario e quello non finanziario. “Attualmente, il settore finanziario ha paradossalmente obblighi più stringenti rispetto alle aziende che vengono finanziate. In altre parole, le imprese che ricevono finanziamenti (hanno obblighi informativi inferiori rispetto a quanto viene richiesto da chi invece li finanzia). Si creano cioè situazioni in cui una banca è tenuta a rendicontare informazioni relative ai propri finanziamenti chiedendo alle imprese (finanziate) informazioni che quelle imprese non sono tenute a produrre per legge.
Si tratta di difficoltà evidenti che hanno origine da un’idea iniziale che prevedeva di utilizzare il settore finanziario come propulsore di un movimento verso la sostenibilità in chiave di investimento competitivo. Una logica corretta dal punto di vista ideale ma che avrebbe bisogno di un quadro normativo adeguato, in grado di eliminare gli squilibri che si sono nel frattempo evidenziati.
Un altro aspetto legato al position paper di BusinessEurope riguarda il coinvolgimento fondamentale di tutti gli stakeholder che operano sul campo. “Fino a poco tempo fa, l’interazione con il mondo operativo è stata marginale – conclude -. È necessario aprire il coinvolgimento agli attori che possono manifestare la loro competenza, specialmente dal lato imprenditoriale e delle organizzazioni che vivono direttamente queste tematiche. L’Omnibus rappresenta una pausa necessaria anche per correggere questo approccio ma prima di tutto è necessario affrontare le problematiche legate alle carenze di certezza del diritto, alle incongruenze tra le direttive e al disallineamento degli obblighi tra settori”.