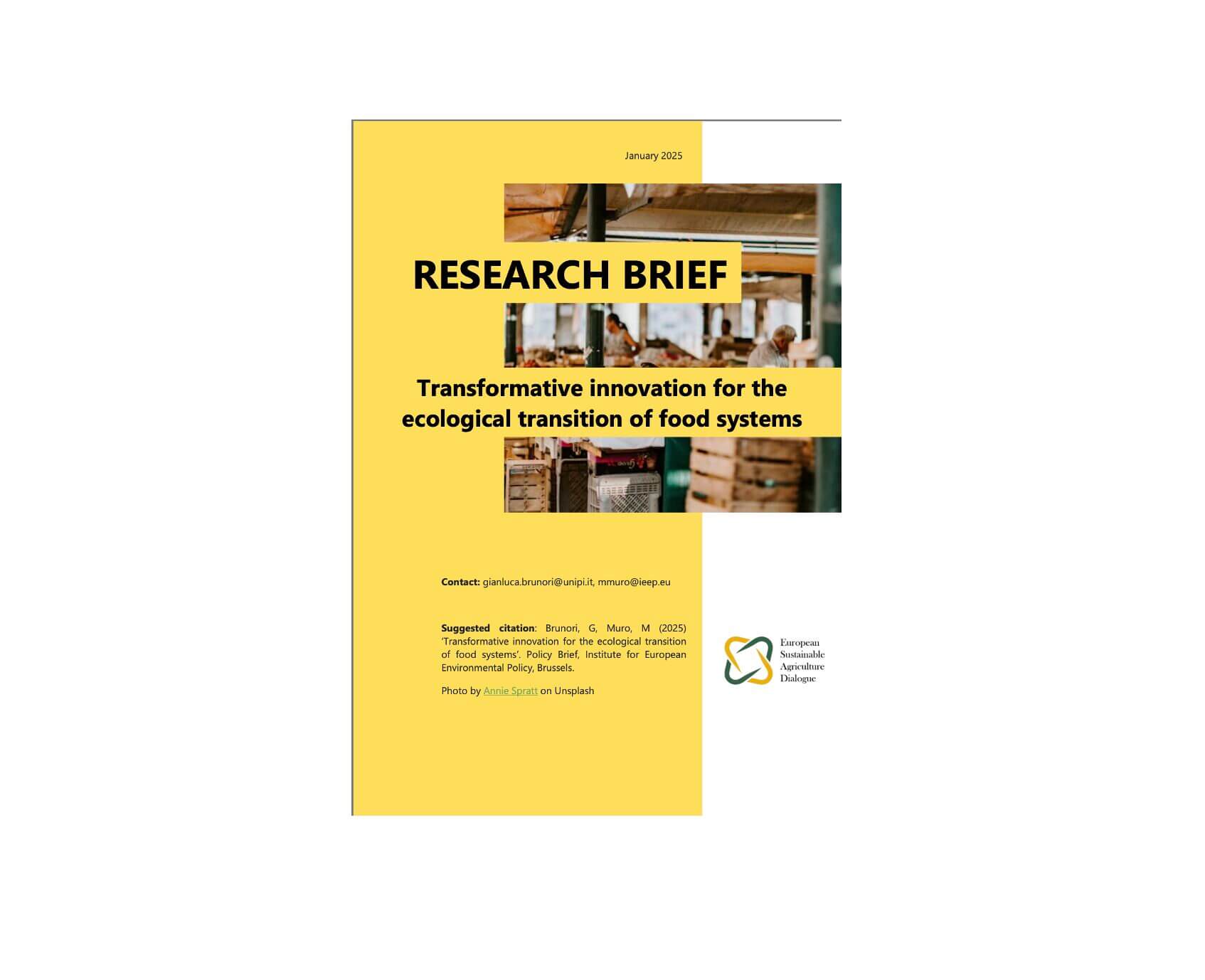Transizione ecologica dei food system: che cos’è e perché è importante?
Negli ultimi decenni, il concetto di transizione ecologica è diventato centrale nel dibattito ambientale, economico e sociale. Quando lo applichiamo ai sistemi alimentari o ai food systems questo concetto assume una valenza particolarmente profonda: non si tratta semplicemente di portare sostenibilità nella produzione agricola, ma di una transizione ecologica dei food system che impone di ripensare tutta la filiera — dalla terra alla tavola — in una logica che rispetti il pianeta, i suoi limiti, le comunità e la salute pubblica.
Transizione ecologica dei food system: quali sono gli ambiti?
Va chiarito innanzitutto che un sistema alimentare comprende tutte le fasi che portano il cibo “dal campo al consumatore”, ovvero che considerano la produzione agricola, la trasformazione, la distribuzione, il consumo, la gestione dei rifiuti. La transizione ecologica di tutti questi sistemi va vista in una prospettiva di ecosistema e significa trasformare ognuna di queste fasi sulla base di una serie di obiettivi che hanno come denominatore comune la sostenibilità e che possono essere così sintetizzati
- attuare una riduzione dell’impatto ambientale, ovvero ridurre le emissioni di gas serra, ottimizzare il consumo idrico, ridurre l’uso di pesticidi, cercare di azzerare l’inquinamento del suolo e delle acque;
- salvaguardare la biodiversità e la salute degli ecosistemi;
- garantire la resilienza contro i cambiamenti climatici, eventi estremi e stress ambientali;
- assicurare sicurezza alimentare e nutrizione per tutti, in modo equo;
- minimizzare sprechi e perdite in ogni fase della filiera.
Perché serve procedere verso la transizione ecologica dei food system?
I sistemi alimentari attuali sono tra i principali responsabili delle emissioni globali di gas serra, della perdita di biodiversità, dell’uso intensivo delle risorse naturali — suoli, acqua, fertilizzanti chimici — e della produzione di rifiuti, compresi gli sprechi alimentari.
Inoltre, i cambiamenti climatici, la volatilità dei mercati, la pressione demografica e le crisi ambientali rendono fragile la produzione alimentare in molte regioni del mondo. Un sistema che non sia sostenibile espone le comunità a rischi crescenti: scarsità d’acqua, degradazione dei suoli, perdita di fertilità, riduzione delle rese, costi crescenti per agricoltori e consumatori.
Quali sono le componenti della transizione ecologica dei food system?
La transizione ecologica nei food system deve sapere agire in forma di ecosistema, ovvero deve considerare diversi piani di azione che possono essere a loro volta così sintetizzati.
- Occorre un’azione a livello di innovazione tecnologica: con pratiche agricole più sostenibili come agricoltura di precisione, agricoltura rigenerativa, uso efficiente dell’acqua, tecnologie digitali di agricoltura 4.0, fertilizzanti più puliti.
- Innovazione sociale e istituzionale prestando attenzione a nuovi modelli di governance, politiche pubbliche che incentivino la sostenibilità, norme ambientali, forme di sostegno per pratiche virtuose e formazione degli agricoltori.
- Si deve poi considerare la necessità di sviluppare e diffondere modelli di consumo responsabile. A questo livello è importante attiare forme di riduzione del consumo di prodotti ad alto impatto ambientale, apianificare un umento dei cibi vegetali, organizzare la produzione su modelli di filiere corte, garantire la trasparenza sull’origine, e ridurre lo spreco domestico.
- Economia circolare e gestione dei rifiuti rappresentano un altro ambito fondamentale dove recupero degli scarti, riciclabilità, compostaggio, riuso, chiusura dei cicli naturali e industriali permettono di cambiare la prospettiva della sostenibilità nel mondo agroalimentare.
- Preservazione della biodiversità e salute del suolo: proteggere gli habitat naturali, azzeramento delle monocolture estensive e parimenti colture di copertura, rotazioni, uso limitato di pesticidi, salvaguardia della ricchezza genetica rappresentano un altro aspetto fondamentale di questa trasformazione.
Quali sono gli ostacoli principali per la transizione ecologica dei food system?
Il percorso per attuare una vera transizione ecologia dei food system presenta fondamentalmente cinque grandi tipologie di ostacoli che devono essere affrontati in modo specifico. La trasformazione presenta un costo, soprattutto nella fase iniziale, certamente elevato. Le differenze in termini di disuguaglianza di risorse e di competenze tra piccole e grandi imprese agricole rischiano di creare condizioni molto eterogenee sul mercato. Non si può pensare a una transformazione ecologica che cambia le modalità di produzione se nello stesso tempo non si superano le abitudini di consumo, spesso molto radicate, presso i consumatori. Alla trasformazione ecologica delle imprese che popolano i food system deve corrispondere anche una innovazione delle infrastrutture che permettono il funzionamento dei mercati. Ultimo, ma non meno importante, il ruolo delle normative che deve essere sempre più coordinato affinché possano essere efficaci senza creare sperequazione tra tipologie diverse di imprese o tra territori.
Perché questo possa accadere occorre che la transizione ecologica dei food systems sia affrontata con una visione sistemica. E per questo è necessario riprogettare il sistema affinché produzioni, consumi, politiche, comportamenti individuali e collettivi siano orientati non al profitto a breve termine, ma al benessere lungo e duraturo del pianeta e delle persone.
Innovazione trasformativa per la transizione ecologica dei sistemi alimentari
Per l’Unione Europea la sostenibilità dei sistemi agroalimentari è un’urgenza strutturale e per comprenderne la valenza e le prospettive è stato predisposto un policy brief preparato dall’Institute for European Environmental Policy (IEEP) intitolato “Transformative innovation for the ecological transition of food systems” (QUI per prendere visione della versione integrale n.d.r). Il report propone un quadro di riferimento per ripensare l’innovazione non come progresso incrementale, ma come leva trasformativa, capace di incidere sul sistema nel suo complesso.
Qual è il contesto: che determina la transizione ecologica dei food system?
Il report definisce l’attuale situazione europea legata ai sistemi alimentari come “permacrisis”. In altre parole non si tratta di un’emergenza straordinaria ma di un insieme continuo di shock. di straordinaria rilevanza come i cambiamenti climatici, eventi meteo estremi, pandemia, difficoltà nelle catene di approvvigionamento, conflitti geopolitici, aumento della polarizzazione sociale, pressione sulle risorse naturali.
Queste crisi mettono in evidenza che le politiche passate, incentrate su produttività, crescita economica e disponibilità, di risorse non bastano più: è necessaria una transizione ecologica che non solo migliori alcuni aspetti, ma cambi le condizioni di base del modo in cui produciamo, trasformiamo, distribuiamo e consumiamo cibo.
Cosa si intende per innovazione trasformativa?
Il report dell’Institute for European Environmental Policy (IEEP) definisce “innovazione trasformativa” come quella forma di innovazione che affronta le cause sistemiche dei problemi (non solo i sintomi), che è nella condizione di sfidare e cambiare le strutture dominanti storiche (istituzioni, pratiche, norme, routine) che possono ostacolare lo sviluppo di modelli pensati per la sostenibilità e la resilienza; e nello stesso tempo che è in grado di combinare innovazione su più dimensioni: tecnologica, sociale, istituzionale, ecologica.
Quali sono le forme di innovazione che possono aiutare la transizione ecologica dei food system?
Per passare dalla teoria alla “pratica” il report indica anche alcuni esempi di innovazione trasformativa che possono stimolare o accelerare la trasformazione ecologica dei food system.
Le soluzioni istituzionali, come i distretti biologici (“organic districts”) che aggregano agricoltori, imprese locali, amministrazioni, organizzazioni civiche per creare reti territoriali con identità, capacità di lobbying, promozione, sviluppo locale.
Le Nature-based solutions come l’agricoltura rigenerativa con pratiche quali rotazioni, colture di copertura, agroforestazione che mirano a ripristinare la salute del suolo, aumentare biodiversità, migliorare la ritenzione idrica.
I modelli sociali come il Community Supported Agriculture (CSA), che sviluppano legami diretti tra produttori e consumatori, distribuzione locale, minor spreco grazie ad accordi stagionali, maggiore trasparenza e coinvolgimento della comunità.
Quali sono le proposte per agire su tutti gli ambiti della transizione ecologica dei food system?
Un punto chiave del report IEEP riguarda la capacità di collegare le crisi presenti con le necessità legate alla transizione ecologica generale, in grado di mobilitare non solo gli esperti, ma anche i cittadini, gli agricoltori, le imprese, le pubbliche istituzioni.
Il policy brief propone tre principali cornici (frame) su cui costruire l’azione politica e di ricerca:
- Frame 1: il legame tra crisi e transizione verde del sistema alimentare — riconoscere che la transizione non è opzionale, ma una risposta necessaria a problemi già in corso, non solo futuri.
- Frame 2: il ruolo degli agricoltori — non come destinatari passivi delle politiche, ma come attori centrali. Serve capire la loro grande varietà (dimensione, modello imprenditoriale, integrazione nei mercati, relazioni con agricoltura locale/mercati globali). Identificare gli incentivi, le capacità, gli ostacoli (capitale, know-how, accesso alle reti).
- Frame 3: politiche per la trasformazione verde — dalla PAC (Politica Agricola Comune) all’insieme delle politiche collegate (ambiente, salute, commercio, ruralità), serve coerenza, coordinamento tra le misure e gli incentivi per premiare gli effetti ecologici e sociali.
Quali sono le principali priorità di ricerca e quali sono le raccomandazioni politiche?
Il report indica anche alcune priorità chiare per indirizzare ricerca, innovazione e politiche:
- Scenari e metodi foresight: studiare non solo il prossimo decennio ma visioni a medio e lungo termine, considerando stressors multipli, possibili shock, come cambiamenti climatici, crisi alimentari, instabilità dei mercati.
- Valutazione di co-benefici e trade-off: ogni innovazione ecologica ha impatti multipli; bisogna misurarli e bilanciarli (es. tra produttività e biodiversità, salute del suolo vs rese, benessere animale vs costi, accettazione sociale vs prezzo)
- Meccanismi di apprendimento e sperimentazione locale: living labs, co-progettazione con agricoltori, comunità, imprese, ricerca per generare adattamenti contestuali. Non esiste soluzione unica adatta a tutte le realtà.
- Politiche che integrano dimensione istituzionale, normativa, incentivi economici: rifocalizzazione della PAC per premiare servizi ecosistemici, premiare pratiche che rigenerano il suolo, che mantengono biodiversità, che riducono uso chimico, incentivare modelli produttivi diversi. Politiche di governance che includano feedback, monitoraggio, coinvolgimento degli stakeholder.
Quali sono le implicazioni per il futuro della transizione ecologica dei food system?
Per orientare efficacemente la transizione ecologica dei sistemi alimentari, il documento suggerisce poi che:
- I fondi di ricerca dell’UE, nazionali, privati dovrebbero essere orientati non solo a nuove tecnologie, ma anche all’innovazione sociale, istituzionale, ecologica; allo sviluppo di modelli che combinino queste dimensioni.
- Le politiche pubbliche dovrebbero essere coerenti e integrate tra loro: PAC, politiche ambientali, salute pubblica, commercio, energia, uso del suolo dovrebbero essere ripensate in modo da essere in sinergia.
- Occorre investire in trasparenza e partecipazione: coinvolgere agricoltori, comunità locali, consumatori, ONG, aziende il tutto in modo che le soluzioni si costruiscano “dal basso e dal contesto”, e che non siano imposte dall’alto.
- Grande attenzione infine al monitoraggio, alla raccolta dati, agli strumenti di valutazione degli impatti ambientali, sociali, economici che dovranno essere rafforzati; e inq uesto ambito occorrono indicatori sempre più chiari per valutare se le innovazioni sono davvero trasformative.