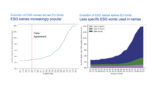La transizione verso le energie rinnovabili è un imperativo globale, non solo per ragioni ambientali, ma anche economiche. La sfida non è solo tecnica, ma anche sociale, politica e ambientale e richiede consapevolezza e collaborazione tra tutte le parti coinvolte.
Implementazione energie rinnovabili: il contesto
Il Green Deal e la Direttiva Europea sulle Energie Rinnovabili (RED III) non solo spingono verso l’espansione delle rinnovabili, ma anche verso una decarbonizzazione accelerata del mix energetico e l’adattamento delle infrastrutture energetiche alle nuove fonti intermittenti, in modo da garantire la flessibilità necessaria per un funzionamento stabile.
Il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) italiano traduce questi obiettivi in scenari concreti, seppur sfidanti. L’Italia, sul fronte delle energie rinnovabili, riporta un obiettivo del 39,4% sul consumo finale lordo di energia. Nel settore elettrico, in particolare, la quota di consumi coperta dalle fonti rinnovabili dovrebbe arrivare entro il 2030 al 63,4%, che comporterebbe la produzione ulteriore di circa 237 TWh di energia.
Le strategie per lo sviluppo delle rinnovabili
Uno dei pilastri fondamentali per il raggiungimento di questi target è l’elettrificazione dei consumi, che significherebbe ridurre l’uso dei combustibili fossili come fonte energetica primaria.
Nel caso dell’Italia, secondo Terna, a marzo 2025 le fonti rinnovabili coprivano il 29,1% della domanda elettrica nazionale, mentre la maggior parte dell’energia prodotta proveniva da combustibili fossili. Nonostante ciò, si è registrato un notevole aumento della capacità rinnovabile installata, che ha raggiunto i 777 MW (+52% rispetto al 2024), segnata soprattutto dalla crescita del fotovoltaico (+24%).
A questo proposito, l’elettrificazione dei processi industriali attraverso tecnologie specifiche ridurrebbe significativamente la dipendenza dal fossile, abbassando i costi e minimizzando l’esposizione alla volatilità dei prezzi del gas e del petrolio. Nei settori ad alta intensità energetica, come quello alimentare e chimico, la sostituzione delle caldaie tradizionali con sistemi elettrici innovativi potrebbe coprire fino all’80% del fabbisogno, offrendo un costo totale di proprietà fino al 61% inferiore rispetto alle caldaie convenzionali.
Gli stessi principi valgono anche per il settore residenziale: le pompe di calore, ad esempio, raggiungono un’efficienza energetica fino a quattro volte superiore rispetto alle caldaie a gas o gasolio, con un risparmio annuo per famiglia compreso tra 380 e 680 euro.
Il ruolo dei veicoli elettrici per la transizione verso le energie rinnovabili
Anche i veicoli elettrici svolgono un ruolo cruciale nella transizione. Promuoverne l’uso attraverso incentivi governativi e infrastrutture di ricarica migliorate non solo ridurrà la dipendenza dai combustibili fossili, ma eliminerà anche le emissioni dirette di gas serra, con conseguente miglioramento della salute nelle città.
Tuttavia, realizzare la transizione energetica va oltre. È essenziale integrare sistemi di accumulo di energia per garantire la stabilità della rete e massimizzare l’utilizzo delle fonti rinnovabili. Secondo il PNIEC, l’Italia dovrebbe integrare nella rete, nei prossimi cinque anni, ulteriori 57 GW di solare fotovoltaico e 17 GW di eolico; Elettricità Futura sottolinea infine che i sistemi di accumulo installati dovrebbero raggiungere gli 80 GWh.
Sistemi di accumulo come asset strategico
I sistemi di accumulo sono un asset strategico per garantire sicurezza e flessibilità alla rete elettrica nazionale, e sono essenziali per centrare l’obiettivo italiano di 107 GW di rinnovabili al 2030 come riportato dal PNIEC. Secondo il Politecnico di Milano, a fine 2024 il nostro Paese contava oltre 700mila sistemi di accumulo installati, corrispondenti a una potenza cumulativa di quasi 6 GW.
Questo obiettivo di crescita è inoltre sostenuto dalla prima asta di Terna per il MACSE (il Meccanismo di Approvvigionamento di Capacità di Stoccaggio Elettrico): un progetto che punta ad accumulare 10 GWh di capacità di stoccaggio entro il 2028. Integrandosi alle tecnologie rinnovabili intermittenti come l’eolico e il solare, il sistema si basa sull’accumulo di energia in esubero per restituirla nelle ore di minore produzione. A livello di business, si tratta di un’opportunità molto allettante soprattutto per gli operatori, in quanto sarà in grado di stabilizzare il mercato accanto alle normali attività commerciali, ai PPA e all’offerta di servizi.
Occorre inoltre che la domanda di energia venga soddisfatta da nuove industrie ad alta intensità di energia elettrica, come i data center, essenziali per l’economia digitale e ad alto consumo energetico. Attualmente, l’Italia ospita il 7,6% dei data center europei e si colloca al quinto posto in Europa (e al dodicesimo a livello mondiale). In Italia, secondo TEHA, il consumo energetico nei data center è destinato a crescere di 42 TWh tra il 2020 e il 2028.
Tendenze future: la velocità di integrazione delle energie rinnovabili è fondamentale
La velocità di integrazione delle energie rinnovabili nei mix energetici in Italia e in Europa è innegabile. Tuttavia, per andare oltre e raggiungere la totale decarbonizzazione, saranno necessari nuovi fattori che accelerino questo processo.
Una di queste continuerà a essere guidata dall’accumulo di energia tramite batterie. Il loro impiego consentirà una gestione più efficiente dell’elettricità rinnovabile, riducendo la dipendenza dai combustibili fossili e migliorando la stabilità della rete e ottimizzando l’integrazione di diverse tecnologie.
Infine, i sistemi di autoconsumo commerciale e industriale svolgeranno un ruolo cruciale nella transizione energetica, con vantaggi come la riduzione della domanda di elettricità “a contatore” e la liberazione di capacità di rete per nuovi consumi, ad esempio per la mobilità elettrica e i data center.
Quali sono le prossime sfide?
Il modo in cui gestiremo questa transizione determinerà non solo il successo nella lotta al cambiamento climatico, ma anche il futuro delle nostre comunità e del mondo che lasceremo alle generazioni future.
Per raggiungere questo obiettivo, dobbiamo disporre di meccanismi dinamici di determinazione dei prezzi dell’energia e di capacità che favoriscano modelli di business sostenibili all’interno della catena del valore, promuovendo il ruolo dell’aggregatore.
Inoltre, la regolamentazione dei servizi di aggregazione è essenziale per gestire in modo efficiente i flussi di energia e ottimizzare la distribuzione delle risorse energetiche.
Il futuro dell’energia è certamente rinnovabile, decentralizzato ed efficiente, ma richiede l’impegno di tutti gli attori chiave. La velocità con cui questo obiettivo verrà raggiunto determinerà la costruzione di un sistema energetico resiliente, competitivo e stabile.