report
Remunerazione CEO e ESG: la sostenibilità fa bene al portafoglio
La remunerazione dei top manager è sempre più spesso collegata ai fattori ESG, attraverso sistemi di incentivazione che legano bonus e premi al raggiungimento di obiettivi ambientali, sociali e di governance.Si tratta di una modalità attraverso la quale la sostenibilità diventa parte integrante della strategia aziendale. Il legame tra performance ESG e compensi serve inoltre ad allineare gli interessi del management con quelli di stakeholder, investitori e società. Arriva dalla Banca d’Italia una analisi comparativa sulla remunerazione legata a fattori ESG per i CEO nelle principali economie europee
Direttore Responsabile ESG360.it, EnergyUP.Tech e Agrifood.Tech
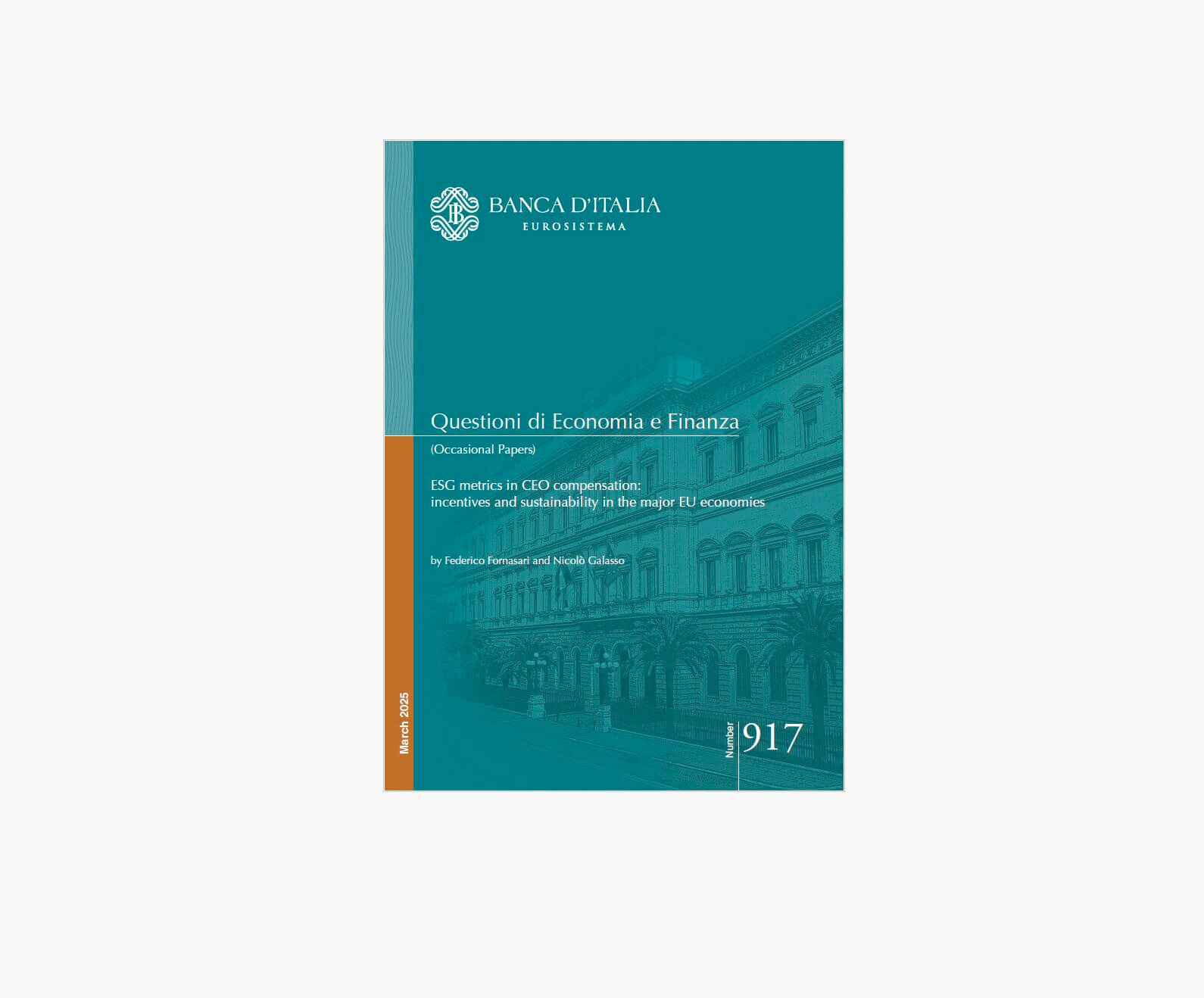
Continua a leggere questo articolo
Canali







